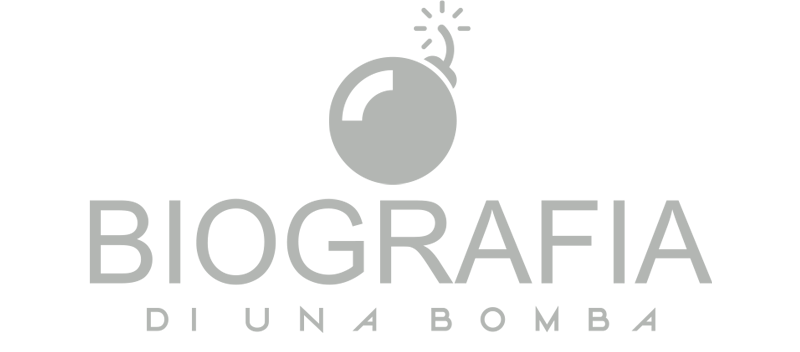Un mare di armi chimiche: 20mila ordigni affondati a partire dal dopoguerra. Oggi lì lavorano i pescherecci pugliesi
Almeno 20 mila ordigni con caricamento speciale a base di aggressivi chimici. TUTTI affondati in una piccola area del Basso Adriatico, al largo del capoluogo Bari e della cittadina di pescatori Molfetta.

Si tratta di bombe chimiche a base di sostanze letali come l’iprite, l’arsenico e forse anche l’uranio impoverito, che stanno devastando il patrimonio ittico e l’ambiente marino. Duecentotrentasei incidenti e ricoveri ospedalieri negli ultimi 45 anni, in cinque casi con esito letale, tra i pescatori che in assenza di divieti hanno continuato a gettare le reti nelle aree infestate, esponendosi alle sostanze fuoriuscite dagli ordigni affondati e corrosi dalla salsedine. Pesci malati e a rischio che continuano a finire sulle nostre tavole. Questa bomba ecologica è il frutto dello smaltimento di munizioni obsolete. Una situazione che è nota alle autorità politiche e militari, ma è stata trascurata.
Solo negli ultimi giorni qualcosa si è mosso per fronteggiare l’emergenza. Subito dopo le rivelazioni de “L’Espresso” sulla lettera scritta un anno fa dal sottosegretario all’Ambiente Valerio Calzolaio all’allora presidente del Consiglio Massimo D’Alema per chiedergli di occuparsi delle bombe all’uranio sganciate in Kosovo. Nella stessa lettera, Calzolaio descrisse come allarmante la situazione delle armi chimiche affondate nell’Adriatico.
Il dossier sugli armamenti chimici nel mare pugliese
Non c’è solo quel documento governativo a fornire un’idea sulla pericolosità degli armamenti chimici che si trovano nel mare pugliese. C’è un dossier dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram), che rappresenta il risultato di due anni (’98-99) di indagini in mare e di campionamento e analisi delle acque e dei pesci. L’area prescelta è il tratto di mare esteso 10 miglia nautiche che si trova a 35 miglia al largo di Molfetta (vedere cartina nella pagina accanto).
«I fondali indagati», recita il rapporto finale del coordinatore delle indagini Ezio Amato, «costituiscono una delle quattro aree di affondamento individuate». Quante altre ce ne sono nel resto dell’Adriatico? Impossibile saperlo: le autorità militari non forniscono informazioni, perché «avrebbero carattere di riservatezza». È certo, invece, che il caricamento dei 20 mila ordigni individuati dall’Icram è costituito da aggressivi a base di iprite e composti di arsenico. In totale, sono state individuate «24 diverse sostanze costituenti il caricamento speciale; di queste, 18 sono persistenti e in grado di esercitare effetti nocivi sull’ambiente».
Ma in cosa consistono questi micidiali ordigni? Come si sono formate le discariche chimiche sottomarine? Quali danni possono procurare?
Sino a una trentina di anni fa, riferisce l’Icram, la pratica corrente di smaltimento di munizionamento militare obsoleto era l’affondamento in mare. Molti residuati del secondo conflitto mondiale hanno seguito questa sorte. Cominciò tutto durante la prima guerra mondiale, quando alcuni paesi belligeranti iniziarono la produzione in grandi quantità di ordigni chimici. Il trattato di Versailles del 1922 e la Convenzione di Ginevra del ’25 misero al bando il loro uso. Nel periodo tra le due guerre, però, molte nazioni continuarono a produrne. Anche l’Italia, soprattutto negli anni Trenta. Centri specializzati per la produzione e lo stoccaggio furono allestiti tra Bari e Lecce. Questi armamenti furono utilizzati nel ’36 in Abissinia, ma dopo la guerra quelli non usati finirono nell’Adriatico. Gli italiani non furono i soli a creare le pattumiere chimiche del mare: fecero lo stesso i tedeschi e gli angloamericani.
Bombe, mine e tutta la “santabarbara” nel mare pugliese
Nel ’47, il servizio pesca della Marina Mercantile emanò questa direttiva: l’affondamento degli ordigni chimici doveva avvenire in fondali di una profondità minima di 460 metri, a una distanza dalla costa di almeno 20 miglia e a 10 miglia dalla rotta di traffico più vicina. Indicazioni poco rispettate: una grande quantità di armi chimiche sono infatti presenti in un tratto di fondale a circa 40 miglia a nord di Bari a una profondità tra 150 e 450 metri. Circostanza che spiega la facilità con la quale si registrano incidenti tra i pescatori (gli ultimi, nel luglio ’96).
In quei fondali c’è una vera santabarbara: bombe a mano, da aereo, da mortaio, mine, quasi tutte a “caricamento speciale”. In alcuni casi l’aggressivo chimico è conservato in bidoni anch’essi adagiati sui fondali. E che, a causa della corrosione, continuano a rilasciare sostanze letali. Vescicanti (iprite e lewisite); asfissianti (fosgene e difosgene); irritanti (adamsite); tossici della funzione cellulare (ossido di carbonio e acido cianidrico). A seconda dei casi, queste sostanze provocano la distruzione delle cellule umane, attaccando occhi, pelle e apparato respiratorio; alterano la trasmissione degli stimoli nervosi.
Negli organismi che ne entrano in contatto, siano esse allo stato liquido o gassoso, le sostanze provocano bruciore, edema, congiuntiviti, congestioni in naso, gola, trachea e bronchi, danni polmonari cronici e asfissia. E non basta: scientificamente provate sono anche le alterazioni genetiche e le aberrazioni cromosomiche. Studi approfonditi sugli effetti sull’uomo sono stati realizzati dal professor Giorgio Assennato dell’Università di Bari, che ha condotto un’indagine su 232 pescatori pugliesi vittime di incidenti tra il 1946 e il ’94. Che si verificano quasi sempre durante la pesca a strascico, tecnica che spazza i fondali imbrigliando gli ordigni nelle reti. Le conseguenze peggiori avvengono per l’esposizione agli agenti tossici, attraverso l’inalazione dei vapori e il contatto cutaneo. Quando non c’è un danno immediato agli occhi, è il sistema respiratorio ad accusare i sintomi più evidenti dell’intossicazione: «Dolore toracico, tosse, ipofonia e faringodinia», scrive nel suo studio Assennato. Seguono tachipnea e broncospasmo a distanza di circa 12 ore. Esposizioni gravi producono la morte per insufficienza respiratoria e polmonite. E, soprattutto, tumori.